Continua la nostra serie di articoli, i quali hanno come scopo quello di conoscere meglio minoranze che con una certa regolarità vengono attaccate per la loro fede. Lo facciamo con il contributo di esperti e profondi conoscitori delle realtà di cui parliamo. Per conoscere sempre meglio i Testimoni di Geova abbiamo intervistato Sergio Albesano, recensore, redattore e storico. Importanti sono le sue denunce sulla violenza, sulla negazione dei diritti fondamentali e sulla lotta per l’obiezione di coscienza. Nel 1992 viene pubblicato il suo libro “Storia dell’obiezione di coscienza in Italia”, che ancora oggi rimane l’unico testo di impostazione storico-scientifica sull’argomento.
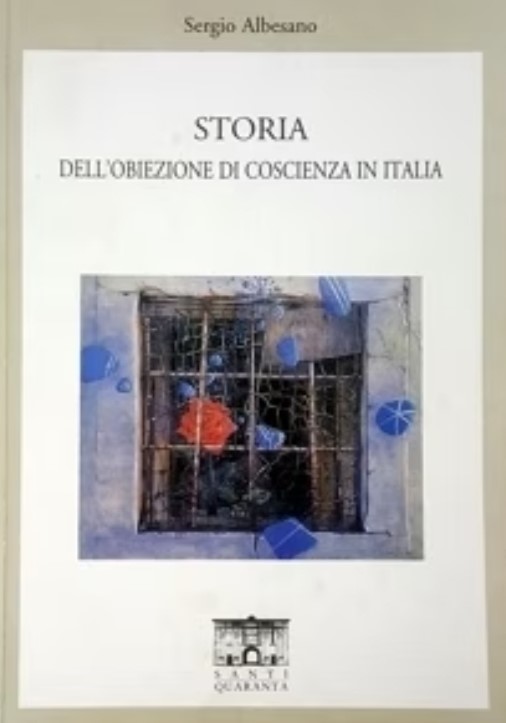
Dott. Albesano, come storico della nonviolenza lei nel 1993 ha scritto un libro intitolato “Storia dell’obiezione di coscienza in Italia”. La sua prefazione al libro terminava con una frase: “Gli obiettori di coscienza e tanto più coloro che prima dell’approvazione della legge hanno pagato con il carcere la fedeltà ai loro ideali, non sono vigliacchi. Essi, per coerenza, hanno affrontato l’indifferenza, la derisione, la calunnia e la repressione. Oggi meritano il nostro rispetto”. Cosa ricorda di quel periodo?
Dopo la legge 772 del 15 dicembre 1972 era possibile svolgere il servizio civile, ma questa scelta per i primi anni risultò una stravaganza praticata da pochi, perché la normalità continuava a essere svolgere il servizio militare. Ho sentito io stesso persone visceralmente contro la guerra definire “vigliacchi” gli obiettori di coscienza! Negli anni Settanta il servizio militare continuava a essere concepito come un rito di passaggio dall’adolescenza alla maturità e in effetti lo era, ma purtroppo nel senso peggiore, perché i ragazzi entravano in caserma con l’irruenza della gioventù e ne uscivano, più che maturi, omologati.
Entravano giovani e ne uscivano vecchi. Era una scuola di uniformità. Un amico mi raccontò che, mentre svolgeva il servizio militare, in una domenica di votazioni politiche il colonnello, davanti alle truppe schierate nel cortile della caserma, affermò (e mi scuso per la crassa volgarità che devo riportare): “Se vi chiedono per chi votate, voi rispondete: ‘Ma la f… è orizzontale o verticale?’!
Chiaro messaggio a estraniarsi dalle questioni politiche, proprio in un periodo storico, la fine degli anni Sessanta, in cui i giovani iniziavano a prendere coscienza delle loro responsabilità politiche e in cui la politica incominciava, anche se con immense difficoltà, a entrare anche in caserma. Il servizio militare continuava a venir considerato come un’affermazione della propria mascolinità e girava ancora il vecchio proverbio: “Chi non è buono per il re non è buono neppure per la regina”. Ci volle tempo, dopo il 1972, perché la scelta dell’obiezione di coscienza prendesse piede e il merito della sua diffusione deve essere attribuita soprattutto a quella parte del mondo cattolico aperto alle istanze di pace.
Il suo libro ha sicuramente contribuito alla legge del 1998 che ha garantito il pieno riconoscimento dell’obiezione di coscienza, attraverso un servizio civile «diverso per natura e autonomo dal servizio militare». Se tale legge fosse ora abolita e fosse ripristinata nel nostro Paese la leva obbligatoria, cosa che ogni tanto qualcuno al governo propone, al momento solo sospesa dal 2004, si riproporrebbe il problema dell’obiezione di coscienza?
Dubito che il mio libro abbia influenzato la promulgazione della legge del 1998. In ogni caso se la leva militare fosse ripristinata, senza dubbio si ripresenterebbero casi di obiezione di coscienza. Penso però che, a parte quelli di motivazione religiosa dei testimoni di Geova, in genere sarebbero numericamente pochi. Dopo la legge 772 che concedeva la possibilità di svolgere un servizio civile al posto di quello militare, pur con diversi limiti e cioè l’autorizzazione da parte di un tribunale che aveva il compito di valutare la correttezza della scelta di coscienza del singolo e comunque imponendogli un periodo di servizio quasi doppio rispetto a quello militare, si era a poco a poco formata una grande massa di giovani, soprattutto grazie all’appoggio di alcune organizzazioni cattoliche, che svolgevano il servizio civile.
Serviziocivilisti
Non si può però affermare che tutti questi giovani fossero davvero obiettori di coscienza. Io personalmente ho sentito alcuni di loro affermare che erano favorevoli all’esistenza delle Forze Armate, nelle quali però non volevano militare. Siamo ovviamente molto distanti dall’obiezione di coscienza. E infatti per definirli fu coniato un neologismo brutto ma chiarificatore: serviziocivilisti. In effetti la maggior parte di loro erano giovani che semplicemente svolgevano un servizio civile offerto dallo Stato e non veri obiettori di coscienza. Infatti obiezione di coscienza e servizio civile non sono sinonimi; infatti si fa il servizio civile, ma si è obiettori. Il rifiuto di un sistema che impone una scelta armata e militarizzata è il momento
dell’obiezione, che poi, grazie alla normativa approvata, si esplica attraverso il servizio civile.
In altri termini, l’obiezione è la volontà politica o religiosa di opporsi a un fatto ritenuto ingiusto; il servizio civile
è l’alternativa offerta dallo Stato. Il fine ultimo dell’obiettore non è quello di evitare di partecipare personalmente alla guerra, ma quello di far cessare tutte le guerre, di far uscire la guerra dalla storia.
L’obiezione di coscienza non deve essere finalizzata alla salvaguardia della propria integrità intellettuale, filosofica o religiosa, poiché ciò ne rappresenta soltanto un momento. Così come deve essere fase intermedia, e non scopo, il riconoscimento della propria opzione di coscienza. L’obiezione non deve servire per affermare il diritto soggettivo di chi obietta, ma il diritto che l’azione cui si obietta andrebbe a violare. In pratica: chi obietta e si rifiuta di sparare non lo deve fare tanto per affermare il proprio diritto a non sparare, anche se ciò è fondamentale, quanto il diritto di vivere di colui contro il quale avrebbe dovuto sparare.
A lei può essere attribuita forse l’ultima intervista che il compianto avv. Bruno Segre rilasciò al convegno “Preferirei di no. Storia, voci e prospettive dell’obiezione di coscienza al servizio militare tra l’Italia e Torino a cinquant’anni dalla legge 772”, svoltosi a Torino il 7 e 8 ottobre 2022. In quell’intervista l’ultracentenario avv. Segre dichiarò: “Mi ricordo alcuni testimoni di Geova. Facevano quattro anni di carcere, cioè quattro volte processati, per non fare dodici mesi di servizio militare. Più buona fede di così!… Dimostrazione di sacrificio. La loro giovinezza l’hanno passata a Peschiera del Garda o a Roma”. Lei pensa che i giovani testimoni di Geova sarebbero ancora oggi disposti a sostenere una posizione come quella anteriore alla legge, descritta dall’avv. Segre?
Conoscendo la fede e la coerenza dei testimoni di Geova non ho dubbi che sarebbero ancora oggi disposti
a sostenere qualunque prova e difficoltà per essere fedeli al Dio in cui credono.
Nelle scorse settimane, con un’ostruzione fatta di trasmissioni televisive costruite e articoli denigratori, i detrattori dei testimoni sono ricorsi alla testimonianza di alcuni fuoriusciti che hanno espresso commenti ostili. Come giudica il ricorso ai fuoriusciti per dimostrare una tesi di non affidabilità di un gruppo religioso inviso?
Sono giornalista e quindi parlo di un ambiente che conosco. Esistono diversi tipi di giornalismo, da quello di Gandhi che concepiva questo mestiere come un modo per far affiorare la Verità a quelli che scientificamente trascorrono la giornata a inventare fake news per manipolare l’opinione pubblica. L’attacco periodico ad alcuni gruppi religiosi o politici è un’arma di distrazione di massa utilizzata da sempre. I romani fecero ricadere sui primi cristiani la colpa delle deficienze dell’impero; Hitler accusò i comunisti dell’incendio al Reichstag; e così via.
Il capro espiatorio
Ogni tanto, quando mancano notizie più importanti o quando si deve evitare che l’opinione pubblica si informi su notizie più importanti, si trova un capro espiatorio da additare al pubblico ludibrio. I testimoni di Geova sono un bersaglio facile, perché su di loro gira tanta disinformazione. Sono un obiettivo facile da attaccare e difficile da difendere. Quindi purtroppo non ci si deve stupire di questi periodici attacchi, che si possono liquidare con un proverbio popolare, “Raglio d’asino non sale in cielo”, o più aulicamente con le parole di Dante: “Non ti curar di loro ma guarda e passa”.
Purtroppo molti danno credito a questi attacchi e la reputazione di questa confessione religiosa ne viene artatamente insultata. Che cosa si può fare? I testimoni possono continuare a vivere con la correttezza morale che li contraddistingue e possono confutare le ingiuste accuse nei loro confronti. Le persone come me che non sono testimoni di Geova ma che hanno avuto la possibilità di conoscere la loro realtà non per sentito dire possono testimoniare la loro moralità, come io sto facendo con questa intervista. Rimane ancora la possibilità che invece questi attacchi non siano o non siano soltanto volti per distrarre le masse, ma che abbiano motivazioni ancora più sporche con finalità politiche ed economiche che non riesco neppure a immaginare.
Lei personalmente come giudica i testimoni di Geova?
Non trovo appropriato il verbo “giudicare”, perché questo non è un processo. Usiamo “valutare”, che mi pare più adatto. Premetto che io sono buddista. Dal punto di vista dottrinale non condivido le posizioni dei testimoni di Geova. Dal punto di vista umano li rispetto per la loro coerenza che è davvero esemplare.


Parla da Uomo libero e dimostra accurata conoscenza dell’argomento, che ha esposto.
Il ragionamento di Sergio Albesano è perfetto. L’obiettore di coscienza non è principalmente un sostenitore di diritti della persona, nel caso di specie la propria. Non “obietto perché sono contro il servizio militare”. Piuttosto, “obietto perché imparare a usare le armi mi porrebbe contro il diritto di vivere della persona contro la quale le armi potrei doverle poi usare”. Fanno venire alla mente le parole pronunciate da un antesignano del “nobile rifiuto” nel pieno della Prima guerra mondiale; il quale, davanti a un collegio militare giudicante, in una frase sintetizzò il rapporto fra la propria coscienza e la ragione motivante che lo ispirava: “La mia coscienza si ribella al pensiero di fare del male al mio prossimo… mai muoverò un dito per recargli del male”. Semplicemente, il principio dell’amore cristiano insegnatoci da Gesù (Remigio Cuminetti, Tribunale Militare di Alessandria, 18 agosto 1916).